
Da quando ho iniziato a lavorare in questo mondo, ho realizzato centinaia di render di interni, di conseguenza ho raccolto una gran quantità di informazioni sulla loro lavorazione. Ho imparato a pianificare il flusso di lavoro prima ancora di iniziare con la parte pratica, ho capito quali sono gli errori più comuni e come evitarli, ho fatto molti esperimenti (tecnici ed estetici) da cui ho ricavato piccoli stratagemmi per facilitare e velocizzare il flusso di lavoro... e tutta questa esperienza mi ha portato (che io lo volessi o no) a sviluppare una capacità che mi risulta oggi molto utile: prevedere il comportamento della luce in base all’anatomia della scena. Una volta acquisita questa conoscenza, non vi servirà più fare tentativi a vuoto sperando in un buon risultato ma saprete come arrivare ad un risultato convincente in modo più diretto.
I render d'interni a cui ho lavorato sono stati sempre più o meno apprezzati, dai miei clienti e dagli studenti che hanno partecipato ai miei corsi (online e dal vivo), e proprio da una domanda frequente che ricevo durante le mie lezioni nasce l'idea di questo post.
È davvero possibile realizzare render d'interni
realistici e confortevoli usando solo luce naturale?
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 1
In questo post trovate la risposta a questa domanda, risposta che per me è arrivata dopo anni di pratica sul campo. Con una serie di esempi vi racconterò quali sono le cose importanti da sapere per creare una buona immagine, sia dal punto di vista estetico che tecnico, attingendo come sempre alla mia personalissima esperienza.

© Lucydreams
Agli occhi di un principiante, che è in una fase della sua vita in cui fa fatica ad ottenere buoni risultati o semplicemente è alle prime armi e non sa ancora bene come funziona un motore di render, può sembrare che dietro la creazione di rendering come questi ci sia un complicato lavoro di costruzione della luce e di impostazioni.
Io stesso, quando ero un principiante, se avessi visto immagini come queste avrei pensato ad un sistema di luci molto complesso, con pannelli luminescenti, sorgenti di luce posizionate in corrispondenza delle finestre, altri punti luce artificiali invisibili piazzati negli angoli o in punti strategici, per creare accenti o riflessioni sui singoli oggetti... e altri escamotage, impossibili da individuare o capire guardando solo il prodotto finito. Con quale logica l'autore sceglie il numero di punti luce, la loro posizione, la loro intensità, la loro grandezza?

© Lucydreams
In realtà queste immagini sono state ricavate da file in cui le uniche fonti di luce erano Corona Sky e Corona Sun. La luce però è solo uno degli ingredienti di questa ricetta. Per completare la ricetta e arrivare a realizzare rendering d'interni davvero belli, usando una fonte di illuminazione apparentemente così semplice come la luce naturale, bisognerà lavorare molto sul design dell'immagine.
L'importanza del design dell'immagine
Lavorare sul design dell'immagine significa:Spendere tempo per trovare la posizione ideale della telecamera
di modo che gli elementi dell'immagine siano nei punti giusti e il campo visivo sia riempito bene
di modo che gli elementi dell'immagine siano nei punti giusti e il campo visivo sia riempito bene
Scegliere bene l'altezza della telecamera dal pavimento
per dare allo spettatore un punto di vista rilassato e rassicurante
per dare allo spettatore un punto di vista rilassato e rassicurante
Individuare la lunghezza focale più appropriata al tipo di immagine che sto creando
perché una visione d'insieme e un particolare richiedono focali diverse
perché una visione d'insieme e un particolare richiedono focali diverse
Usare la profondità di campo, ovvero la messa a fuoco
per aumentare il realismo dell'immagine ma anche per indirizzare lo sguardo dello spettatore sul soggetto
per aumentare il realismo dell'immagine ma anche per indirizzare lo sguardo dello spettatore sul soggetto
Stabilire con intelligenza il formato dell'immagine in base all'anatomia del soggetto
sfruttando gli effetti diversi del formato landscape e del formato portrait
sfruttando gli effetti diversi del formato landscape e del formato portrait
Selezionare il tipo di prospettiva in base al tono che voglio dare all'immagine
frontale per un tono più serio ed elegante; accidentale per un tono più spontaneo e naturale
frontale per un tono più serio ed elegante; accidentale per un tono più spontaneo e naturale
Dare alla luce la direzione e la delicatezza giusta
e alle ombre la densità e la morbidezza ottimali
e alle ombre la densità e la morbidezza ottimali
Sviluppare l'immagine per ottenere un look naturale
regolare con equilibrio l'esposizione, il contrasto, la saturazione dei colori ed evitare le bruciature
regolare con equilibrio l'esposizione, il contrasto, la saturazione dei colori ed evitare le bruciature
Inserire uno sfondo visibile attraverso le finestre nel modo più corretto
che non abbia una prospettiva sbagliata, che non sia troppo scuro (o troppo chiaro)
che non abbia una prospettiva sbagliata, che non sia troppo scuro (o troppo chiaro)
Applicare le nozioni di base del design d'interni
nella scelta degli arredi e degli accessori e dello stile generale
nella scelta degli arredi e degli accessori e dello stile generale
Mettere lo storytelling sempre in prima posizione
comporre l'immagine con l'intenzione di portare lo spettatore a sentirsi parte di una storia
comporre l'immagine con l'intenzione di portare lo spettatore a sentirsi parte di una storia
Usa questa checklist durante la creazione delle tue immagini e verifica di aver pensato a tutto.
Queste sono le cose su cui a mio parere vale veramente la pena di lavorare, di spenderci del tempo. È il modo in cui si padroneggiano questi punti che fa realmente la differenza tra un render di un principiante e uno di un professionista esperto. Queste competenze si acquisiscono solo con tanto lavoro, con un po' di tempo, e soprattutto studiando non tanto le impostazioni del software, che comunque è importante conoscere ma che — se scegliete di utilizzare Corona — sono veramente poche, ma piuttosto studiando le nozioni essenziali di fotografia, composizione dell'immagine, teoria del colore, storytelling e design d'interni.
Creare un’immagine non è solo una questione tecnica, bisogna prima sapere cosa fa “bella” un'immagine. Spesso questo obiettivo si perde di vista per concentrarsi sulle impostazioni del programma e sulla ricerca di asset esterni che risolvano i problemi. Scaricare pacchetti di texture ad altissima risoluzione, o materiali iper complessi pensando che possano essere miracolosi, o ancora corsi online a 5 Euro che promettono successo immediato dopo 2 ore di lezione, sono tutte cose che vi faranno perdere solo tempo e soldi.
Da dove cominciare? (Da un buon modello 3d)
Sembrerà strano ma se volete arrivare a realizzare rendering di interni che funzionino veramente bene, dovete prima sapere alcune cose fondamentali sulla costruzione del modello 3d, e mettere in pratica alcuni importanti accorgimenti.Il modello 3d deve essere in scala reale
Se state lavorando su un modello 3d fuori scala, la simulazione della luce non sarà del tutto corretta
Se state lavorando su un modello 3d fuori scala, la simulazione della luce non sarà del tutto corretta
Lo spazio deve essere chiuso su tutti i lati
non sfondate mai pareti e non inserite luci invisibili altrimenti l'illuminazione risulterà innaturale
non sfondate mai pareti e non inserite luci invisibili altrimenti l'illuminazione risulterà innaturale
I vetri possono essere spenti
per via della sovraesposizione del paesaggio esterno, con o senza vetri il risultato non cambierà
per via della sovraesposizione del paesaggio esterno, con o senza vetri il risultato non cambierà
Il file deve essere possibilmente organizzato bene
rinominate e raggruppate con disciplina, altrimenti il disordine nel file si rifletterà sull'immagine
rinominate e raggruppate con disciplina, altrimenti il disordine nel file si rifletterà sull'immagine
Il tuo modello 3d rispetta queste 4 regole?
Le dimensioni contano
Perché il modello 3D deve essere in scala reale
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 2
Utilizzare un modello 3d in scala reale è più importante di quanto si possa pensare. Corona (un po' come tutti i motori di render) crea un'immagine, una rappresentazione, di come la luce circolerebbe in uno spazio reale. Per farlo, utilizza una certa quantità di fotoni virtuali, che si comportano come le "particelle" di luce nel mondo reale. Il numero di questi fotoni viene scelto in base alle dimensioni dello spazio, ed è per questo che è importante che quello spazio abbia le dimensioni corrette.
Per capire meglio perché sarebbe sbagliato lavorare con un modello 3d fuori scala, pensate a questo: la luce simulata da Corona si comporta come l’acqua. Quando ne versate una piccola quantità in un bicchiere da una bottiglietta, la forma che assume il flusso d’acqua è molto liscia e ha una anatomia molto semplice. Se guardate una cascata il movimento che l’acqua compie è grossomodo lo stesso: si sposta da una quota più alta ad una più bassa, ma la forma che il corpo dell'acqua assume in questo caso è molto diversa, perché il numero di particelle d’acqua coinvolte in questo movimento è drammaticamente più alto.


Se il modello 3d è fuori scala, ad esempio molto più piccolo di quanto sarebbe nella realtà, la simulazione viene eseguita con un numero di particelle sbagliato, e non sarà del tutto corrispondente a quello che vedremmo nel mondo reale in uno spazio di quelle dimensioni. L’immagine infatti sarebbe più simile ad una foto di un modellino in scala. La stessa cosa succederebbe se il modello 3d fosse molto più grande di quanto dovrebbe essere, ad esempio se invece di misurare 3 metri da pavimento a soffitto misurasse 30 o 300 metri. L’immagine, di nuovo, non mostrerebbe una simulazione corretta.
Non è obbligatorio modellare in scala reale fin dal primo minuto, nella prima fase del vostro lavoro potete anche modellare senza badare troppo alle dimensioni degli oggetti o della struttura architettonica, basterà verificare che il vostro modello 3d sia in scala reale poco prima di lanciare il render. Io, ad esempio, quando sto modellando qualcosa di molto piccolo, lavoro intenzionalmente fuori scala, per avere più comodità nei movimenti e nell'applicazione dei comandi.
Dal buio al realismo
Come ottenere una buona luce senza barare
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 3
Quando si è principianti e si è alle prese con i primi render di interni, il problema principale è la luce: molto probabilmente le prime immagini vi verranno buie, scure, con poca luce. Questo succede perché di solito le finestre sono poche e piccole rispetto alla superficie della stanza — a meno che non stiate lavorando ad uno spazio con aperture molto grandi.
Questo è il momento in cui un principiante, come ero io qualche anno fa, inizia a pensare che il problema vada risolto con degli escamotage, come ad esempio:
Captain Corona
 @capcorona • 15 settembre 2025
@capcorona • 15 settembre 2025
Io elimino sempre la parete alle mie spalle, così entra più luce! Se non si vede non mi serve.
Questo pensiero è molto sbagliato, anche quando non si parla di eliminare intere pareti ma solo oggetti, anche piccoli, perché la luce circola diversamente se quell'oggetto c’è o non c’è. Sfondando pareti o soffitti solo perché non si vedono, di fatto entrerà molta più luce ma entrerà inondando lo spazio in modo irreale. Se la parete eliminata è quella alle spalle della camera, la situazione sarà la peggiore possibile, perché con la luce alle proprie spalle l'immagine verrà completamente piatta. Quindi non eliminate mai pareti per far entrare più luce, perché questo non risolve il problema. @capcorona • 15 settembre 2025
@capcorona • 15 settembre 2025Io elimino sempre la parete alle mie spalle, così entra più luce! Se non si vede non mi serve.


Correct lighting
Wrong lighting
Prof. Texture
 @proftex • 15 settembre 2025
@proftex • 15 settembre 2025
Io metto sempre una luce omni invisibile al centro della stanza, così mi illumina tutto!
Aggiungere luci invisibili in punti impossibili solo per avere più luce è una cosa che se non viene fatta con intelligenza porta a illuminazioni brutte e assolutamente non realistiche. La cosa peggiore che si possa fare è piazzare una luce omni al centro della stanza, che appiattirà tutto. Non ha neanche molto senso riempire la scena con luci aggiuntive nei punti più scuri, perché questo complica la gestione del vostro file e nella maggior parte dei casi rende tutto molto finto. Non fraintendete questo consiglio: in qualche caso è utile aggiungere delle luci di rinforzo fuori dall'inquadratura per schiarire le parti più buie o creare riflessi su metalli o vetri per rendere tutto più interessante, ma bisogna farlo dopo aver acquisito un po' di esperienza.
 @proftex • 15 settembre 2025
@proftex • 15 settembre 2025Io metto sempre una luce omni invisibile al centro della stanza, così mi illumina tutto!
Doctor Pixel
 @docpixel • 15 settembre 2025
@docpixel • 15 settembre 2025
Se il render mi viene scuro nessun problema: risolvo tutto con Photoshop!
Oggi Photoshop fa miracoli ma è sempre importante creare una buona immagine di base. E poi con Photoshop si può soltanto partire dal render così com'è e renderlo complessivamente più luminoso, aumentarne il contrasto generale, alterarne i colori, ma è molto difficile trasformare la luce e renderla migliore se in partenza è totalmente sbagliata.
 @docpixel • 15 settembre 2025
@docpixel • 15 settembre 2025Se il render mi viene scuro nessun problema: risolvo tutto con Photoshop!

© Lucydreams
E se al primo render la stanza sembrerà buia è normale, non c’è niente di sbagliato. Basterà alzare l’esposizione della camera, correggere le bruciature e regolare il contrasto generale e tutto funzionerà molto meglio.
Qui sotto vedete le 4 fasi di sviluppo di un'immagine: 1. render di partenza (buio); 2. scelta dell'esposizione; 3. correzione delle bruciature; 4. regolazione del contrasto. Come vedete il risultato finale non è più buio, ma è correttamente esposto, piacevolmente luminoso e con il giusto livello di contrasto.
Il punto è che spesso un principiante, come ero io qualche anno fa, non sa molto di come funzionano la percezione della luce e l’esposizione. E magari non sa come correggere le bruciature una volta alzata l’esposizione, per questo pensa di dover tenere l’esposizione bassa e cercare altri modi per avere più luce, perché "è così che funziona". Ma così si finisce per credere che la realizzazione di una bella immagine sia un'operazione molto random, stressante e faticosa. La frustrazione può portarvi a mollare e a pensare che questo sia un lavoro di merda molto faticoso. Ma è solo perché non si hanno (ancora) le competenze per affrontare questo lavoro nel modo più logico.
Vetri delle finestre e bruciature
Quando e perché nascondere i vetri nel render
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 4
Se il mio obiettivo è imparare a creare un render di interni con luce naturale in versione diurna devo allenarmi osservando molto bene le fotografie di interni, che saranno il mio punto di riferimento. Quella che vedete qui sotto è una (bella) fotografia di un interno in stile scandinavo.

Fonte: Google
Concentratevi sul paesaggio esterno. Come vedete, è difficile percepire la presenza dei vetri delle finestre, perché il paesaggio esterno è talmente luminoso da risultare accecante, e cancella qualsiasi riflesso o indizio sulla presenza del vetro. Quando in una fotografia una zona dell'immagine è così tanto luminosa si dice che è bruciata, o sovraesposta, termini che si riferiscono al fatto che l'esposizione è talmente alta (rispetto all'esposizione corretta) da ridurre tutto ad una chiazza bianca.
A volte una bruciatura può essere considerata un errore, quando il suo effetto è sgradevole, ma in una foto scattata all'interno di una casa come questa, la sovraesposizione del paesaggio esterno visibile attraverso le finestre non è un errore, e non è neanche fastidiosa, perché tutto sommato siamo abituati a vedere foto di interni con i paesaggi esterni del tutto o quasi del tutto bruciati.
Ma perché il paesaggio esterno viene bruciato? Per raffigurare correttamente la luce che circola all'interno della stanza, il fotografo sceglie di tarare l'esposizione della camera sulla quantità di luce presente all'interno della stanza, e non su quella all'esterno, che è maggiore. In altre parole ha scelto di impostare l'esposizione per ottenere una bella immagine dell'interno, molto luminosa e accogliente, sacrificando la visibilità dell'esterno che risulterà bruciato.

In conclusione, in un render di interni con luce naturale diurna (e non notturna — in quel caso è meglio che i vetri siano visibili) posso nascondere i vetri delle finestre perché nel render finale non saranno visibili per via della bruciatura del paesaggio esterno. In questo modo la luce entrerà nello spazio più liberamente, non dovrà passare attraverso il vetro e il motore di render farà meno calcoli.
Mr. Render
 @mrrenderreal • 15 settembre 2025
@mrrenderreal • 15 settembre 2025
Tutto molto bello, ma il mio cliente vuole vedere il cielo azzurro e non bianco.
È possibile che dopo aver letto questo paragrafo vi stiate chiedendo: "è corretto che quello che si vede fuori dalle finestre rimanga così luminoso? Non è sbagliato? Il mio cliente mi chiede sempre di correggere questo errore e vedere il cielo azzurro e non bianco. Come mi devo comportare in questi casi?" @mrrenderreal • 15 settembre 2025
@mrrenderreal • 15 settembre 2025Tutto molto bello, ma il mio cliente vuole vedere il cielo azzurro e non bianco.
Le foto che vedete qui sopra e qui sotto (scattate da Angelo Talia), specialmente quella di destra, vi dimostrano come la bruciatura dell'esterno sia assolutamente normale in una fotografia di un interno. Detto questo, è plausibile che la persona per cui stiamo lavorando ci chieda di vedere il cielo azzurro o il paesaggio esterno esposto correttamente. Non perché non sa nulla di fotografia ma perché il nostro occhio vede diversamente (potremmo dire che ha una "tecnologia" superiore a quella della macchina fotografica): è in grado di esporre correttamente tutte le zone del nostro campo visivo, così quando l'immagine arriva al nostro cervello non percepiamo sottoesposizioni e sovraesposizioni, ci sembra tutto più o meno esposto correttamente.
Quindi su un piano intuitivo o estetico, l'esterno completamente bianco può sembrare strano, astratto.
Il mio consiglio è cercare di convincere, se possibile, il cliente ad accettare la bruciatura dell'esterno, magari spiegandogli queste cose e mostrandogli degli esempi.
Ci sono però dei casi in cui questa richiesta è più che legittima: i casi in cui è importante vedere bene sia l'esterno che l'interno, i casi in cui una necessità narrativa, artistica o anche (perché no?) economica è più importante dell'integralismo tecnico.
La camera da letto raffigurata in queste foto è la stanza di un BnB, a Roma, che gode di un'ottima vista sulla cupola di San Pietro. Se dovessi consegnare un'immagine come questa al cliente, l'esterno non potrebbe essere sovraesposto altrimenti non si vedrebbe la cupola, che colloca il BnB in pieno centro storico; al tempo stesso l'interno della stanza non potrebbe essere troppo sottoesposto, altrimenti sembrerebbe molto buio e poco accogliente. Se alzo l'esposizione si vede bene l'interno ma l'esterno è bruciato. Se abbasso l'esposizione si vede bene l'esterno ma l'interno è buio.

Foto di Angelo Talia
File ordinato, mente lucida
Organizzare bene i file non serve alla luce, ma serve a te
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 5
Chi mi conosce di persona sa che in alcuni contesti sono un fanatico dell'ordine e della precisione, e il modo in cui organizzo i file delle mie scene è uno di quei contesti. Rinominando e raggruppando i miei file sempre con la stessa logica riesco quasi sempre a trovare molto velocemente quello che mi serve, anche utilizzando il motore di ricerca della finestra Oggetti. Per questo trovo molto utile farlo, e non lo ritengo un fanatismo fine a sé stesso. Un file ordinato rende il lavoro più semplice e meno stressante.
Mi piace tenere nella prima parte della lista le Telecamere, rinominate in base a quello che inquadrano (es.: "Camera 01 - living", "Camera 05 - particolare cucina", etc); nella seconda parte della lista tengo sempre le Luci (Corona Sun e Corona Sky, più tutte le altre eventuali luci abbinate ai modelli di lampade che ho nella scena); nell'ultima parte della lista posiziono i gruppi che contengono le parti del Modello 3d, suddivisi in Struttura (muri, pavimenti, soffitti, pilastri, insomma le parti strutturali della scena) e Arredi, raggruppati in base agli ambienti della scena (living, cucina, bagno...) e alla loro categoria (arredi principali, complementi d'arredo e accessori).

Ovviamente non è obbligatorio organizzare il file in questo modo, perché il comportamento della luce non dipende da questo. Se il file, o meglio la lista degli oggetti, è totalmente disordinata e i nomi degli oggetti sono messi a casaccio, la luce farà lo stesso il suo lavoro. Però se state leggendo questo post e siete arrivati fin qui, probabilmente è perché vi fidate un po' della mia esperienza. E allora fidatevi anche di questo consiglio: spendete 5 minuti del vostro tempo a riordinare il file e rinominare gli elementi. Sembra una pratica inutile, invece incide in modo decisivo sulla concentrazione, sulla lucidità e sulla calma che riuscirete a mantenere durante tutta la lavorazione delle vostre immagini.
Scegliere gli arredi giusti
Applicando le nozioni di base del design d'interni
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 6
Io non ho studiato per diventare un designer d'interni, tutto quello che so su questa materia l'ho imparato sul campo, leggendo qualche libro, sfogliando molte riviste, e chiacchierando con persone più esperte di me che ho conosciuto durante questi anni di lavoro. Il design d'interni è una disciplina molto vasta, però ci sono alcuni princìpi di base che possono essere applicati in modo pratico durante la preparazione della vostra scena (uno di questi era già implicito nel paragrafo precedente sull'organizzazione del file) e che nel mio caso mi hanno aiutato tantissimo a sviluppare una logica stilistica nello scegliere i pezzi d'arredo da inserire nelle immagini a cui ho lavorato.

© Lucydreams
In poche parole, il Cosmos Browser e tutti i siti web da cui si possono scaricare modelli 3d sono una risorsa utilissima, però la enorme disponibilità di modelli 3d di qualsiasi tipologia, stile, epoca e dimensione, ha anche un lato negativo: c'è tanta, troppa scelta. E chi non sa cosa scegliere finisce per selezionare arredi e accessori a caso che non sempre stanno bene insieme.
Nello scegliere come riempire la scena, bisognerebbe prima pensare a quale stile seguire (scandinavo, minimal, vintage, etc) e poi utilizzare modelli 3d in quantità, tipologia, colore e materiali, che appartengano a quello stile, cercando di non uscire troppo fuori strada e seguendo le regole di base del design d'interni.

© Lucydreams
La parola stile si usa nella moda, nella musica, nel ballo, nello sport, nel design delle automobili e in molti altri mondi. Nel mondo del design d’interni, la parola stile indica l’insieme di scelte che il designer di interni ha fatto durante lo sviluppo di un progetto, e che hanno donato a quello spazio un’identità precisa, una personalità, un carattere che lo distingue dagli altri.
Quando guardiamo una foto di un interno, a prescindere dal livello di competenze che abbiamo, tutti siamo più o meno in grado di distinguere un design equilibrato, armonioso, che rispecchia cura nei dettagli e buon gusto, da uno sviluppato in modo frettoloso e senza criterio. Spesso però non è semplice spiegare perché quegli accostamenti di colore o di pezzi di design o di materiali di finitura stiano così bene insieme, pur provenendo da epoche storiche o aree geografiche differenti, e se non si afferrano i motivi di quell’equilibrio difficilmente si riuscirà a replicarlo in un proprio progetto.
L’interior design è una disciplina molto vasta, ma esistono dei princìpi di base elementari che possono aiutarci a muovere i primi passi in questo mondo nel modo migliore, e a capire come creare delle composizioni di design con metodo e buon senso, e che non sembrino improvvisate senza un piano.
Per non allungare troppo questo articolo, vi raccoglierò queste nozioni in un post dedicato a questo tema. Troverete il link qui appena sarà pronto.
Arredi, complementi e decorazioni
3 categorie di oggetti per arredare in modo realistico
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 7
Verso la fine del mio lavoro spesso guardo la mia immagine e mi chiedo: "forse dovrei riempire di più gli spazi e aggiungere qualche altro oggetto? O forse la scena è già troppo affollata e dovrei semplificare e togliere qualcosa?". Non è facile dare una risposta a queste domande perché ogni spazio ha bisogno di una soluzione diversa, però può essere utile partire da qui: una scena d'interni funziona bene se ha un numero adeguato di oggetti e se si possono suddividere in queste 3 categorie:
Arredi principali di grandi dimensioni e con forte personalità stilistica
(divani, poltrone, tappeti, tavoli, lampadari, sedie, mobili di grandi dimensioni)
(divani, poltrone, tappeti, tavoli, lampadari, sedie, mobili di grandi dimensioni)
Complementi d'arredo secondari
(lampade da terra, coffee table, sgabelli, piante da interni, tende, mobili di piccole dimensioni)
(lampade da terra, coffee table, sgabelli, piante da interni, tende, mobili di piccole dimensioni)
Accessori/Decorazioni
(libri, fiori, soprammobili, quadri, piantine, cuscini decorativi, interruttori, prese di corrente)
(libri, fiori, soprammobili, quadri, piantine, cuscini decorativi, interruttori, prese di corrente)
Difficilmente mi dimentico di inserire gli arredi principali, anche perché sono le prime cose che scelgo e dalla loro posizione dipenderà più o meno tutto il resto dell'arredamento, però mi può succedere di metterne troppi o troppo pochi. Per questo motivo è sempre meglio selezionare 4 o 5 arredi protagonisti al massimo, non di più.
Una volta aggiunti gli arredi principali, non devo lasciarli soli ma li devo abbinare a dei complementi d'arredo secondari e adeguati, prima ancora di pensare alle decorazioni. Se mi preoccupo solo di aggiungere accessori e decorazioni, alla visione di insieme mancherà qualcosa e i pezzi principali sembreranno solitari e isolati.
Se nella scena ci sono solo arredi principali e complementi ma nessun accessorio, lo spazio sembrerà in attesa di qualche particolare che lo renda vivo. Libri, fotografie, fiori, quadri, non andrebbero mai scelti a caso ma sempre con l'intento di raccontare qualcosa sui gusti e sulla personalità di chi abita quello spazio.
Questi ultimi sono quelli con cui si costruisce lo storytelling e sono quasi più importanti degli arredi principali. Per questo spendo sempre molto tempo a creare le copertine dei libri che inserisco nelle mie scene o a scegliere i soggetti dei quadri. Uso molto raramente asset predefiniti come i soliti libri di architettura con copertine bianche e nere (visti e stravisti mille volte in centinaia di render d'interni). Naturalmente tutto questo non c'entra niente con la luce naturale, ma se un'immagine è arredata male non c'è luce che possa abbellirla.
Luce e inquadratura
Come orientare la camera per ottenere la luce migliore
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 8
Ritornando alla domanda principale a cui questo post vuole dare una risposta: è davvero possibile realizzare render d'interni realistici e confortevoli usando solo la luce naturale? La prima parte della risposta è: sì, a patto che il modello 3d sia costruito con intelligenza. Questo però non basta: anche la telecamera deve essere posizionata con intelligenza rispetto alla direzione da cui arriva la luce. Ma cosa significa "posizionata con intelligenza"?
Se voglio ottenere una buona luce, un buon chiaroscuro, devo fare in modo che lo spazio e gli oggetti raffigurati nella mia immagine abbiano un lato in luce e un lato in ombra, in questo modo risulteranno tridimensionali e tangibili. Nel posizionare la telecamera nella mia scena devo prima di tutto capire da dove arriva la luce e la direzione che percorre nello spazio, e poi cercare di mettermi in una posizione tale da ottenere una buona fotografia, ossia un buon contrasto tra luce e ombra.
1. Luce che arriva dalle spalle della camera
Se la luce arriva dalle spalle della camera, tutti gli oggetti che ho di fronte saranno completamente illuminati e rischieranno di risultare piatti e monocromatici. Per questo motivo, creare una buona immagine con la fonte di luce principale alle proprie spalle è un po' più complicato, ma non impossibile.
In questo caso, ad esempio, per evitare che la stanza risultasse piatta, è stata messa una tenda davanti alla finestra (per evitare che entrasse troppa luce), il sole è stato abbassato al tramonto, direzionato in modo tale che creasse un raggio di luce diagonale (per rendere più movimentata la lettura dell'immagine) e nella stanza sono stati aggiunti dei punti di luce artificiale qua e là per creare delle aree di micro contrasto.

© Lucydreams
La porta d'ingresso socchiusa (da cui si intravede la luce che arriva dall'altra stanza), la porta scorrevole del bagno semi aperta (come anche quella dell'armadio), la coperta un po' mossa e la ricchezza di pattern nei materiali sono tutte scelte intenzionali per creare più punti di interesse nell'immagine che non facciano sentire troppo la mancanza di una luce più "caravaggesca".
2. Controluce
Se la luce è di fronte a me (quindi se sono controluce) gli oggetti raffigurati nella mia immagine saranno tutti in ombra e avrò la stessa difficoltà a creare un buon chiaroscuro. Il controluce infatti è una situazione complessa, anche per un fotografo esperto, perché la luce è molto forte, ma se si abbassa troppo l'esposizione per non esserne accecati il resto dell'immagine rischia di rimanere troppo al buio.
Le stesse soluzioni di prima possono essere utili anche per risolvere bene un'immagine controluce. Nel caso non bastassero, può essere utile salvare il render con due esposizioni diverse e poi fare un mix tra le due esposizioni in post produzione, un po' come per l'esempio della camera da letto del BnB a San Pietro di cui vi stavo parlando prima.
La soluzione migliore in questi casi consiste nell'aggiungere (se possibile) delle aperture a destra o sinistra, fuori dal campo visivo della telecamera, da cui far entrare una piccola quantità aggiuntiva di luce naturale, come è stato fatto nell'immagine qui sotto, per migliorare il chiaroscuro della parte sinistra in primo piano che veniva un po' piatta.

© Lucydreams
3. Quasi controluce
Dato che non si tratta di un controluce vero e proprio, perché la telecamera non è perfettamente perpendicolare alla parete che ha di fronte ma è posizionata in un angolo della stanza e punta verso l'angolo opposto, potremmo chiamare questa situazione "quasi controluce".
Qui sotto vedete la scena scandinava che avete visto poco fa con uno schema che indica la posizione della camera e la direzione della luce.

© Lucydreams
A mio parere, questa è la scelta con cui si ottiene la luce più interessante. Non è così difficile da gestire come un vero controluce né tantomeno rischia di risultare banale o scontata come nel caso in cui la luce arriva perfettamente da destra o da sinistra. In moltissime immagini a cui ho lavorato, la luce è stata strutturata in questo modo, perché si ottiene una fotografia eccellente quasi al primo colpo, la prospettiva accidentale non è troppo geometrica e rigida, ma risulta spontanea e naturale, la luce quasi frontale è un’opportunità di giocare con i bagliori e aggiungere un tocco di poesia, e le finestre possono mostrare uno sfondo con cui estendere la visione del pubblico e farlo sentire in uno spazio reale, magari che affaccia su un giardino.
4. Luce che arriva da destra o da sinistra
Un risultato altrettanto interessante si può ottenere con la telecamera perfettamente perpendicolare alla parete opposta e con la luce che viene da destra o da sinistra. Una situazione molto facile da gestire quindi anche particolarmente utilizzata da principianti alle prime armi.
Nell'esempio qui sotto la camera è perfettamente perpendicolare alla parete di fronte, la prospettiva è perfettamente centrale e tutte le linee orizzontali e verticali sono perfettamente dritte e parallele tra loro. La luce arriva da sinistra.

© Lucydreams
Il risultato è indubbiamente buono, con un forte contrasto tra luce e ombra, potremmo dire un chiaroscuro "caravaggesco", in riferimento a Caravaggio che nei suoi dipinti raffigurava quasi sempre una luce di questo tipo, creando una netta divisione tra luce e buio, e ottenendo immagini (oltre che evocative e drammatiche) che hanno ancora oggi un realismo e una profondità eccezionali.

A mio modo di vedere le cose, una configurazione di questo tipo in un render di interni (oggi) inizia ad essere forse un po' scolastica e scontata. Se posso, cerco di optare per un quasi controluce o un controluce vero e proprio.
Due prospettive, due stili
Frontale ed elegante VS Accidentale e spontanea
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 9
Come avete visto nel paragrafo precedente, in base a dove scegliete di posizionare la telecamera, potete ottenere due tipologie diverse di inquadratura: se la camera è perfettamente perpendicolare alla parete che ha di fronte, la prospettiva sarà frontale/centrale, e tutte le linee orizzontali e verticali presenti nell'immagine saranno totalmente dritte e parallele tra loro; se invece la camera è in un angolo della stanza e guarda verso l'altro angolo, allora la prospettiva sarà accidentale.

Quale scegliere? Dipende un po' dall'anatomia del soggetto che avete di fronte e dal tono che volete dare all'immagine. Le prospettive frontali danno un taglio più serio ed elegante all'immagine, mentre con le prospettive accidentali le immagini risultano meno calcolate e più spontanee. Una prospettiva frontale è particolarmente adatta ad ambienti o soggetti che hanno già di per sé un qualcosa di più rigoroso e solenne, viceversa le prospettive accidentali raccontano lo spazio raffigurato nell'immagine con un linguaggio più naturale e confidenziale quindi si rivolgono all'osservatore con un tono più amichevole.

© Lucydreams
Entrambe le soluzioni sono ottime per i render delle varie zone di un'interno e per questo motivo quando lavorate ad una serie di immagini ricavate dalla stessa scena è sempre importante optare sia per prospettive frontali che accidentali, anche per fare in modo che quando il vostro pubblico sfoglierà le immagini una dopo l'altra si annoi il meno possibile. Se usate sempre lo stesso tipo di inquadratura il vostro portfolio rischia di diventare ripetitivo e un po' prevedibile.

© Lucydreams
Pensate anche a questo: quando siete a casa e vi spostate da un ambiente all'altro, difficilmente vi muovete in modo robotico seguendo direzioni parallele o perpendicolari ai muri che vi circondano, come farebbe la torre degli scacchi. Nella normalità ci muoviamo più liberamente nelle nostre case, senza badare troppo alla direzione del nostro spostamento, e attraversiamo molto spesso le stanze in diagonale. Questo significa che nella maggior parte del nostro tempo, con i nostri occhi vediamo lo spazio che ci circonda in una prospettiva accidentale, che è quella a cui di conseguenza siamo più abituati e che ci risulta più digeribile.
Il punto di vista umano
A che altezza posizionare la camera nei render di interni?
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 10
Nel 2002 mi sono iscritto alla Facoltà di Architettura di RomaTRE e ho iniziato a seguire i corsi di progettazione. Gli elaborati finali consistevano in disegni tecnici come piante, sezioni, prospetti e qualche prospettiva, che all'epoca qualcuno disegnava addirittura a mano (anche se circolavano già i primi render realistici). Parlando di prospettive e rendering, praticamente tutti i docenti che ho avuto raccomandavano sempre di raffigurare i propri progetti da una cosiddetta "altezza uomo", ovvero ricostruendo la visione di un osservatore alto 1.70/1.80 che guarda il progetto dalla quota stradale, dal marciapiede o dal pavimento (se si trattava di un interno), per restituire l'immagine e la forma che sarebbe stata effettivamente percepita dalle persone che avrebbero visto quell'edificio o vissuto quello spazio. E lo trovo un consiglio molto sensato.

Quando poi ho iniziato a lavorare e la mia vita mi ha portato a creare più rendering di interni che di esterni, mi sono reso conto che posizionare la telecamera a 1.80 di altezza in un interno non sempre portava a buoni risultati. I risultati migliori – dove per "migliori" intendo quelli che piacciono di più a me e vengono apprezzati di più dai miei clienti – li ottengo posizionando la telecamera ad un'altezza minore, compresa tra 80/90 centimetri e un metro, o 1.20/1.50 al massimo (dal pavimento).

© Lucydreams
C'è anche una ragione psicologica dietro questa scelta: la prospettiva che abbiamo di fronte ai nostri occhi quando siamo in piedi è diversa da quella che abbiamo quando siamo seduti, perché i nostri occhi sono più in alto o più basso. Mettere la camera più in basso serve a creare una prospettiva più simile a quella che vediamo quando siamo seduti, rilassati, quindi porta l'osservatore a sentirsi rilassato, seduto comodamente su una poltrona o su un divano presente nella stessa scena, e a immergersi più facilmente nella visione di quello spazio.

© Lucydreams
Quindi l'immagine di una scena da questa altezza è più rilassante e rassicurante della stessa immagine creata da un punto di vista più alto. Per questo nelle mie immagini difficilmente vedrete telecamere ad altezza uomo, salvo qualche eccezione dettata da esigenze tecniche o richieste del cliente.
Lunghezza focale: che cos'è e come scegliere quella giusta
Dal dettaglio alla visione d’insieme
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 11
Come avete capito, questo post non parla solo di luce naturale nei render d'interni. Stiamo parlando di come creare immagini che vadano oltre, che siano belle e realistiche (usando solo luce naturale). Soffermiamoci un attimo sul realismo, che spesso è l’obiettivo numero uno di chi lavora in questo mondo. Che cosa vuol dire “realistico”? Un'immagine creata al computer è realistica quando è molto simile alla realtà, in altre parole molto simile al modo in cui vediamo il mondo reale attraverso i nostri occhi.
C’è un’impostazione della telecamera che può incidere in modo decisivo sulla percezione del realismo: la lunghezza focale. Nell’obiettivo di una macchina fotografica, la lunghezza focale è la distanza tra il centro ottico (che in parole povere è il punto della lente in cui si concentra la luce) e il sensore (il "microchip" che raccoglie la luce e la trasforma in un'immagine), espressa in millimetri.

Nel momento in cui viene creata, una telecamera nasce con una lunghezza focale di default di 35 mm.

Quando modificate la lunghezza focale il campo visivo si allarga o si restringe. Aumentando la lunghezza focale facciamo una sorta di zoom sull’immagine, stringendo su un dettaglio; diminuendola allarghiamo l’inquadratura tornando alla visione d’insieme.

Qual è la lunghezza focale
con cui si ottiene il maggior realismo?
Se vogliamo dare una risposta più rigorosa a questa domanda, diciamo più "scientifica", allora dobbiamo partire da quanto è ampio il campo visivo catturato dall’occhio umano. Il nostro sistema visivo è formato da due occhi uno accanto all’altro, ognuno con un suo campo visivo individuale. Quando i dati raccolti dagli occhi arrivano al cervello, il cervello elabora questi dati creando un’immagine mentale complessiva di quello che c’è di fronte a noi, sommando i campi visivi dei singoli occhi. Il risultato è che abbiamo un campo visivo orizzontale di circa 180/190° gradi.
Il punto è che la nostra mente non ci permette di vedere in modo chiaro tutto ciò che è compreso in questi 180°: abbiamo una visione nitida e dettagliata sulla parte centrale di questo enorme campo visivo (limitata ad una porzione di circa 40/45° dei 180° totali) ma nelle parti più esterne, periferiche, tutto ci appare più sfocato e indefinito. Per questo chiamiamo le due zone del nostro campo visivo visione centrale e visione periferica.

La visione centrale e quella periferica non sono però separate da una linea netta. Non c’è un punto preciso in cui finisce la visione centrale e inizia quella periferica. Sfumano una nell’altra. Quindi finché scegliamo focali comprese tra i 20/25 mm e i 70/80 mm (con cui abbiamo un campo visivo compreso tra i 70° e i 30°) stiamo creando un’immagine abbastanza realistica perché corrispondente alla visione umana. (Ovviamente si possono scegliere focali anche minori di 20 e maggiori di 80, ma queste sono quelle più logiche quando si lavora ad un render d'interni).
Se ci allontaniamo molto da questi valori ad esempio scegliendo focali da sotto i 15 mm o sopra i 300 mm il campo visivo sarà troppo diverso da quello umano e le deformazioni ottiche (nel caso di una focale molto corta) o lo schiacciamento della distanza tra primo piano e sfondo (nel caso di una focale molto lunga) potrebbero risultare non realistiche.
Oltre il realismo: effetti ottici da teleobiettivi e grandangoli
Attenzione, non realistiche non significa necessariamente brutte, anzi. Quella che vedete qui sotto è una foto della “super luna” dietro il Tempio di Poseidone a Capo Sounion, in Grecia scattata con un teleobiettivo (ovvero una lunghezza focale lunghissima) da Constantine Emmanouilidi. La foto è autentica, non è stata alterata in post produzione. Lo schiacciamento della distanza tra primo piano e sfondo è un tipico effetto dell'uso di queste focali.
Queste invece sono due foto di Willem Jonkers, scattate con dei grandangoli, o Fisheye, ossia delle lunghezze focali molto corte. La stranezza nelle proporzioni e le distorsioni percepite in questi casi sono tipiche dell'uso dei grandangoli.

Quindi posso scegliere una lunghezza focale qualsiasi
tra 20/25 mm e 70/80 mm. Che focale scelgo?
Dipende da cosa sto inquadrando e da quanto voglio che sia ampia la mia inquadratura. Se sto impostando una camera per una vista generale, complessiva, una focale corta (20/25 mm) sarà la scelta più sensata (e quasi obbligata perché il campo visivo deve essere molto ampio per poter includere tutto o una gran parte dello spazio che ho di fronte). Con una focale lunga (70/80 mm) sarebbe molto complicato farlo.

Viceversa, se sto impostando una camera per un particolare (un cosiddetto closeup) una focale lunga (70/80 mm) funzionerà meglio.

Se sto lavorando ad un'immagine che non è troppo generale né troppo ravvicinata, che potremmo definire un'immagine "a campo medio", una focale "normale" (intorno ai 50 mm) sarà la scelta più efficace.
Quello che non bisogna fare è il contrario: usare una focale corta per un particolare e una focale lunga per una vista generale.
La focale corta permette visioni molto ampie ma altera leggermente la forma dello spazio, specialmente nelle zone più esterne dell’inquadratura, e se usata per un closeup vi costringerà ad avvicinarvi troppo al vostro soggetto, ne distorcerà le proporzioni e vi darà una percezione irreale della distanza tra primo piano e sfondo. Una focale lunga vi permette di rimanere ad una distanza più adeguata dal soggetto ma schiaccia un po' la distanza tra primo piano e sfondo — cosa che riduce il dinamismo dell’immagine, rilassa la visione, dà proporzioni più eleganti a ciò che è raffigurato e favorisce la concentrazione dell’osservatore sul soggetto.
La focale corta permette visioni molto ampie ma altera leggermente la forma dello spazio, specialmente nelle zone più esterne dell’inquadratura, e se usata per un closeup vi costringerà ad avvicinarvi troppo al vostro soggetto, ne distorcerà le proporzioni e vi darà una percezione irreale della distanza tra primo piano e sfondo. Una focale lunga vi permette di rimanere ad una distanza più adeguata dal soggetto ma schiaccia un po' la distanza tra primo piano e sfondo — cosa che riduce il dinamismo dell’immagine, rilassa la visione, dà proporzioni più eleganti a ciò che è raffigurato e favorisce la concentrazione dell’osservatore sul soggetto.
Landscape VS Portrait
Come scegliere il formato migliore
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 12
Nelle parti precedenti ho iniziato a parlarvi delle immagini distinguendole per tipologie in base al loro campo visivo: generali, medie e closeup. Come avete capito la scelta della lunghezza focale è strettamente legata alla tipologia di immagine che stiamo componendo. Ma c'è un'altra scelta che spesso un principiante fa fatica a fare con un criterio preciso ed è la scelta del formato.
Un’immagine è sostanzialmente una porzione del nostro campo visivo racchiusa in un rettangolo che può avere diversi formati. La parola formato indica la proporzione tra la base e l’altezza di questo rettangolo.

Se la base e l’altezza sono uguali, il formato dell’immagine è quadrato (1:1); se la base e l’altezza sono differenti, il formato è rettangolare. Nel linguaggio della fotografia, quando l’immagine è racchiusa in un rettangolo orientato in orizzontale, il suo formato è detto landscape, che tradotto letteralmente dall’inglese significa “paesaggio”, ovvero il tipo di soggetto che normalmente viene fotografato tenendo la camera orientata in orizzontale. Il formato landscape a sua volta può avere varie proporzioni, come 4:3, 3:2, 16:9.

© Lucydreams
Se invece il rettangolo ha un orientamento verticale, allora il formato è detto portrait, che significa “ritratto”, termine che si associa più facilmente all’immagine di una persona, a mezzo busto o a figura intera.

© Lucydreams
Di solito per le immagini complessive ha più senso scegliere un formato landscape perché lo scopo di queste immagini è mostrare la visione d'insieme e quindi permettere allo spettatore di esplorare anche il lato destro e sinistro dell'immagine. Quando posso scegliere liberamente, un formato che mi piace molto utilizzare è il 3:2, ma è semplicemente il mio gusto personale.

Per le inquadrature a campo medio e i closeup mi piace utilizzare un formato portrait in 3:4.

Non è obbligatorio scegliere altezza e larghezza attenendosi alle proporzioni dei formati standard (4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 16:9). Si possono scegliere le proporzioni più funzionali al soggetto che vogliamo raffigurare e alla composizione della nostra immagine.
Perché è importante usare formati diversi?
Quando il nostro lavoro consiste nel creare 2 o più immagini di una stessa scena (un interno o un esterno) è molto probabile che, una volta terminate, le immagini vengano pubblicate insieme in un post o in una slideshow, per cui il pubblico le sfoglierà una dopo l’altra. Se le immagini hanno tutte lo stesso formato, è probabile che chi le osserva si annoi prima di arrivare in fondo alla serie. Se le immagini hanno formati diversi riusciranno ad intrattenere meglio il pubblico.Scegliendo un formato landscape piuttosto che un formato portrait si può “guidare” lo sguardo dell'osservatore, accompagnandolo sul percorso ideale, quello che permette di apprezzare meglio ciò che è raffigurato nell’immagine. Le immagini in formato landscape spingono l’osservatore a esplorarle seguendo un percorso orizzontale; al contrario, mentre osserviamo un’immagine in formato portrait, è più probabile che i nostri occhi si muovano su una linea verticale.

La scelta di un formato diverso da quello di default rispecchia anche un lavoro di ricerca delle varie soluzioni possibili, l’intenzione da parte dell'autore di valorizzare il proprio soggetto racchiudendolo in un rettangolo di proporzioni ideali, più appropriate alla sua forma e non lasciare questo aspetto al caso. Abituarsi sempre allo stesso formato equivale a lasciare inesplorati questi effetti.
Come gestire la messa a fuoco nei closeup
Dal realismo allo storytelling
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 13
Ora sappiamo che i render di una scena d'interni possono essere suddivisi in 3 categorie: generali, a campo medio e closeup. Abbiamo delle indicazioni su come scegliere la lunghezza focale in base alla categoria e al soggetto che stiamo raffigurando, su come comportarci se la luce arriva da una direzione piuttosto che da un'altra, e sappiamo anche selezionare (e riconoscere) una prospettiva frontale o una accidentale e un formato portrait o un formato landscape.
Ora soffermiamoci per un attimo sulle inquadrature a campo medio, ma soprattutto sui closeup.
Quando il nostro spettatore osserva una serie di immagini ricavate dalla stessa scena, si aspetta di scoprire quella scena partendo da una visione d'insieme per poi scendere gradualmente nei dettagli. Ecco perché di solito le immagini generali sono le prime della serie. A volte a me succede il contrario: la mia attenzione viene catturata da un closeup, perché magari è molto suggestivo e ricco di dettagli tecnici iperrealistici. Quella prima immagine mi incuriosisce e mi spinge a cercare informazioni sull'autore e recuperare le altre immagini della serie. In quei casi l'esperienza va al contrario: dal particolare alla visione d'insieme.

© Lucydreams
I closeup, proprio perché raffigurano solo pochi dettagli o un particolare da vicino, sono immagini in cui si riescono a trovare meglio gli "indizi" sulla storia che l'autore vuole raccontare. In altre parole, a chi la vede per la prima volta, una visione d'insieme è utile per prendere le misure con le scena (dimensioni, stile, luce, abbinamenti di colore). I closeup invece si spostano su un piano diverso, quello dello storytelling.
C'è un passaggio tecnico che se non viene eseguito correttamente impedisce ai closeup di risultare realistici, e quindi rovina un po' anche la loro capacità di raccontare la storia. Sto parlando della profondità di campo, ossia la messa a fuoco della camera.

© Lucydreams
Questo effetto è presente in tutte le fotografie, di qualsiasi tipo, da quelle di paesaggio più ampie ai ritratti più intimi. Una macchina fotografica reale infatti non può mettere a fuoco tutto ciò che vede, dagli oggetti più vicini in primo piano a quelli più lontani sullo sfondo. Il fotografo deve scegliere cosa mettere a fuoco e cosa lasciare fuori fuoco. Una volta scelto il fuoco (detto in maniera più tecnica: una volta scelta la distanza focale, ovvero la distanza tra la camera e il piano di fuoco) il fotografo può scegliere di includere più o meno oggetti nella zona a fuoco, regolando la profondità di campo (che si regola aprendo o chiudendo il diaframma).

La porzione di spazio più o meno profonda in cui si trovano gli oggetti dell’immagine che sono tutti perfettamente a fuoco viene detta “campo”, da qui il termine profondità di campo. Per questo motivo, se la camera che stiamo usando per il nostro closeup ha la messa a fuoco disattivata, ci mostrerà sempre tutto a fuoco e di conseguenza saremo un passo indietro rispetto al realismo delle fotografie.

© Lucydreams
V-Ray man
 @vrayman • 15 settembre 2025
@vrayman • 15 settembre 2025
Però in alcune foto sembra che sia tutto a fuoco, sia il primo piano che lo sfondo. Com'è possibile?
Il fotografo può regolare il raggio della sfocatura modificando l’apertura di diaframma: con un diaframma aperto il raggio della sfocatura è molto più grande; con un diaframma chiuso la sfocatura sarà ridotta al minimo e gli elementi dell’immagine sembreranno tutti a fuoco, come nella foto qui sotto. "Sembreranno" perché se guardate bene la parte inferiore dell'immagine vedrete che un minimo di sfocatura c'è e si vede. @vrayman • 15 settembre 2025
@vrayman • 15 settembre 2025Però in alcune foto sembra che sia tutto a fuoco, sia il primo piano che lo sfondo. Com'è possibile?

Fonte: Google
Nello scegliere le impostazioni della sua macchina fotografica, un fotografo alle prese con una foto complessiva, ha l’obiettivo di far ricadere l’attenzione sulla visione d’insieme e non su un dettaglio, perciò riduce al minimo la sfocatura degli oggetti in primo piano e sullo sfondo, chiudendo il più possibile il diaframma. Per questo motivo, se lasciamo disattivata la messa a fuoco nei nostri render generali, risulteranno ancora piuttosto simili alle fotografie di questo tipo, in cui la messa a fuoco è intenzionalmente ridotta al minimo e quasi impercettibile.

© Lucydreams
Nei closeup invece l’obiettivo è diverso: concentrare l’attenzione su un particolare. Per questo motivo nei closeup la profondità di campo è sempre molto limitata, e la sfocatura è sempre molto forte.
Per ottenere una buona profondità di campo, mentre sto posizionando la telecamera su un particolare, come la composizione di oggetti nel render qui sotto, devo cercare un punto da cui osservare il mio soggetto che mi permetta di avere qualcosa in primo piano da mettere fuori fuoco e - possibilmente - uno sfondo abbastanza distante dal soggetto che si possa sfocare al punto giusto. Chi guarda l'immagine non deve avere dubbi su chi sia il protagonista.

Non è facile scegliere l'apertura di diaframma "giusta". Quando ero alle prime armi tendevo ad esagerare con la sfocatura, per sfoggiare questo effetto, che però poi era talmente forte da risultare una cafonata. Con il tempo e con l'esperienza, e guardando molte fotografie reali da cui prendere spunto, ho ingentilito la mia mano e ho capito che la cosa migliore è rappresentare una sfocatura leggera, sobria, che basti a dare all'immagine quel tocco di naturalezza in più ma che non sia eccessiva.

Morbidezza della luce
Luce nordica VS mediterranea
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 14
Quasi tutte le immagini che avete visto in questo post hanno una luce "morbida". I raggi di sole entrano negli ambienti proiettando ombre dai contorni molto sfumati. Anche questa è una scelta che può incidere molto sul realismo e sulla bellezza di un render d'interni in cui c'è in gioco solo la luce naturale.
Possiamo scegliere se la luce solare proietterà ombre dai contorni netti e definiti o più sfumati e morbidi, modificando due opzioni del Corona Sun: Size e Intensity.
Se state usando un altro programma e un altro motore di render (ad esempio V-Ray) può essere che queste opzioni si chiamino in modo diverso e che si trovino da qualche altra parte nel vostro pannello di controllo ma una volta trovate potrete applicare la stessa logica e ottenere lo stesso effetto anche se non usate Corona.
Size controlla la dimensione del disco solare (e di conseguenza la morbidezza delle ombre) e va da un minimo di 0 a un massimo di 64. Inserendo un valore intorno a 25 o 30 si ottiene un buon risultato ma dipende molto dal tipo di inquadratura e dal tipo di scena su cui state lavorando, quindi per trovare l'impostazione migliore dovrete fare qualche prova con valori diversi (ad esempio una con 20, una con 40 e una con 60), confrontare i risultati e scegliere quella che vi convince di più.
Aumentando Size, le ombre proiettate dalla luce solare diventano più morbide, come se il sole fosse coperto da una nuvola. Per questo motivo, dopo aver aumentato Size ha molto senso diminuire anche Intensity, inserendo un valore tra 0.2 e 0.5, per ottenere una luce meno violenta e che si appoggia in modo più delicato sulle superfici.


Corona Sun [Size = 20 / Intensity = 0.3]
Corona Sun [Size = 1 / Intensity = 1]
Raffigurare una luce morbida è una scelta particolarmente appropriata quando le scene a cui stiamo lavorando devono avere uno stile scandinavo/nordico, e più in generale alle scene già ricche di particolari e accessori, perché non aggiunge altre linee o pattern che potrebbero creare confusione o distrazione.
La scelta di usare una luce netta è più logica quando sto creando un'immagine di un ambiente minimal, spoglio e asciutto, perché in un'immagine in cui non c'è quasi niente per scelta, un raggio di sole che attraversa la stanza o colpisce un oggetto può arricchire, dare personalità e rendere la lettura dell'immagine più interessante. Una luce solare più forte e definita è anche molto adatta ai render di una scena ambientata in paesi mediterranei, dove il clima è più caldo e l'associazione mentale più immediata è il sole dell'estate.
I clienti per cui ho lavorato in questi anni hanno quasi sempre preferito una luce morbida per le loro immagini, e anche quando ho lavorato ad una serie di immagini per il mio portfolio (in cui ho potuto esprimere molto liberamente il mio stile) ho sempre scelto una luce morbida piuttosto che netta, perché l'effetto mi piace di più. Ma è una questione di gusto personale.
Sfondi e paesaggi esterni
Come inserirli senza rovinare il render
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 15
Nella parte dedicata alla bruciatura delle finestre avete visto come sia del tutto legittimo creare un render di un interno con vedute esterne completamente sovraesposte o quasi. Questa pratica rende anche più facile la lavorazione delle immagini, perché inserire uno sfondo esterno, nonostante a parole possa sembrare una sciocchezza, non è un'operazione semplice, e se non viene fatta con attenzione può rovinare tutto il lavoro fatto fino a quel momento.
Detto questo, nei casi in cui non è troppo complicato farlo e non crea distrazioni, l'inserimento di uno sfondo riesce a rendere l'immagine molto più interessante e completa, perché ci dà un "contesto", ci dice dove ci troviamo e permette all'occhio dell'osservatore di andare mentalmente più in profondità nella lettura dello spazio.

© Lucydreams
Ci sono vari modi di inserire uno sfondo visibile dalle finestre di un'interno:
1. Photoshop (post produzione)
La tecnica più semplice consiste nell'aprire l'immagine con Photoshop, scontornare l'esterno utilizzando il canale Alpha del render (o nel modo che preferite) e aggiungere come livello di sfondo la foto del paesaggio che volete vedere all'esterno. Questo però non è sufficiente. Per arrivare ad un risultato corretto dovrete:Cercare un'immagine con una buona risoluzione
Che non raffiguri cose troppo vicine o lontane
Con una prospettiva che non vada in conflitto con la prospettiva del render
Scattata con una lunghezza focale simile a quella usata per il render
L'orizzonte della foto dovrà coincidere con l'orizzonte dello spazio 3d
E dovrete simulare la bruciatura tipica dei paesaggi esterni visti da un interno.
L'ultima forse è la parte più difficile e delicata, perché schiarire l'immagine è una cosa che può essere fatta in mille modi diversi e non è facile imitare la sovraesposizione che si verificherebbe se quel paesaggio fosse stato realmente fotografato con un'esposizione alta dall'interno di una stanza. In questo caso lo sfondo è un mix di due fotografie a cui ho dovuto associare vari livelli di regolazione prima di arrivare ad un risultato soddisfacente, e le impostazioni di questi livelli non sono mai le stesse, cambiano ogni volta che cambia il paesaggio, perché ogni foto è diversa e richiede regolazioni differenti.


2. Applicare la foto su un piano 3d (nel file)
In questo caso la foto è inserita in un materiale, e quel materiale viene applicato ad un piano delle stesse proporzioni, posizionato fuori dalla stanza e perpendicolare allo sguardo della camera. Anche in questo caso valgono le stesse regole di prima ma non avrete bisogno di modificare l'esposizione dello sfondo in post produzione, perché verrà automaticamente sovraesposto.
© Lucydreams
3. Costruirlo in 3d (nel file)
Se volete farvi del male, uno sfondo, sia urbano che naturale, può essere anche costruito tutto in 3d. Scherzi a parte, oggi rispetto a qualche anno fa è molto più facile seguire questa strada perché è molto più semplice trovare asset di questo tipo, anche di ottima qualità. Non dovete neanche cercare troppo lontano perché nel Cosmos Browser trovate molti modelli 3d di alberi, edifici e tutto ciò che serve per costruire una piccola porzione di una città o un giardino.

Nell'immagine qui sopra (per un'agenzia immobiliare di Roma), il giardino esterno è stato costruito interamente in 3d, e non è bruciato. Questo perché anche l'esposizione dell'interno non è altissima come le altre immagini che avete visto in questo post, ma soprattutto perché era importante che il giardino privato di questo appartamento fosse ben visibile.
Bloom & Glare
Reale VS artistico?
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 16
Se dall'interno di una stanza scattassimo una foto inquadrando una finestra (durante il giorno) oppure una lampada o ancora un raggio di sole intenso che colpisce il piano di un tavolo. utilizzando l'esposizione tipica che si usa per le foto di interni, le parti più luminose dell'immagine (soprattutto se controluce) mostrerebbero un effetto di bagliore diffuso sui contorni che possiamo chiamare Bloom.

Fonte: Unsplash
In un rendering con Corona, il Bloom non appare in automatico, bisogna attivarlo dalle impostazioni del VFB o dalle opzioni della Corona Camera, e regolato (utilizzando Bloom intensity) di modo che non sia eccessivo o impercettibile: per risultare realistico deve essere simile a quello che vedremmo in una fotografia, per questo è ancora più importante osservare tante fotografie e concentrarsi sul memorizzare il look di questo effetto.
Questo effetto, in maniera diversa, si verifica anche nei nostri occhi quindi è nella nostra "memoria visiva". Molti principianti abusano con il Bloom e lo considerano un tocco artistico, e in effetti aggiunge poesia all'immagine, la fa sembrare l'immagine di un sogno, ma in realtà è una cosa che ha a che fare con il realismo dell'immagine. Se non c'è il Bloom dove i nostri occhi si aspettano di trovarlo, quell'immagine non sarà realistica al 100%.


Il Bloom è una delle due opzioni che trovate nel VFB, nel menu Bloom and Glare. Il Glare serve a raffigurare i riflessi lente (lens flare) tipicamente serali/notturni causati da luci puntiformi intense, come i fari di un'auto che viaggia verso la camera, quindi nelle immagini con luce naturale in cui non ci sono luci di questo tipo ha più senso disattivarlo (Glare intensity = 0) e lasciare visibile solo il Bloom.
Contrasto e realismo
Gli occhi sono la "reference" migliore
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 17
In uno dei capitoli di questo lungo post vi ho parlato del rapporto che c'è tra posizione della camera e direzione d'ingresso della luce nella scena, facendo riferimento a Caravaggio e al contrasto estremo delle sue immagini. Quando guardiamo un dipinto, un disegno o un qualsiasi altro tipo di immagine, la sensazione di tridimensionalità è data soprattutto dal chiaroscuro e dal contrasto. Quando il contrasto viene a mancare o viceversa è eccessivo, tutto risulterà piatto o fastidiosamente illegibile. Per questo controllare con intelligenza il livello di contrasto tra la luminosità delle parti in luce e l'oscurità delle parti in ombra di un'immagine è un passaggio decisivo per arrivare ad un buon realismo nei render d'interni.
Osservate quest'immagine. È molto difficile dire che sia bella. Ma perché è "oggettivamente" brutta? Perché il contrasto di quest'immagine è stato intenzionalmente portato a valori disumani, dove per "disumani" si intende troppo lontani dal livello di contrasto con cui noi vediamo il mondo reale attraverso i nostri occhi.

Il contrasto ideale è sempre quello che dona all'immagine un aspetto il più possibile naturale. Se ci pensate, "realistico" significa "corrispondente a come noi vediamo il mondo reale attraverso i nostri occhi". La quantità di luce percepita (ovvero l'esposizione), il livello di contrasto tra luce e ombra, la saturazione dei colori, la distanza percepita tra primo piano e sfondo, la larghezza del nostro campo visivo, la morbidezza nei contorni delle ombre proiettate dalla luce del sole, e persino l'intensità con cui si sfocano le cose su cui non stiamo puntando il nostro sguardo, sono tutte cose che vediamo quotidianamente, ma raramente le osserviamo con l'obiettivo di memorizzarne l'aspetto e replicarlo nei nostri render.
Quando camminate per strada o su un sentiero di montagna, quando esplorate un museo o siete a casa a leggere un libro, o mentre guardate un raggio di sole che entra nella vostra stanza al tramonto, le informazioni che vi servono per ricreare un'immagine realistica di quello che vedete in quel momento sono tutte già scritte di fronte a voi e potete leggerle gratuitamente, dovete solo imparare a farlo!
Usare HDRi nei render d'interni
L'illuminazione basata su HDRi è davvero imbattibile?
Creare render d'interni realistici usando solo la luce naturale → Parte 18
Nei casi in cui gli artisti che seguo hanno condiviso il loro flusso di lavoro ed è stato possibile per me vedere come avevano impostato l'illuminazione nei loro progetti, spesso la luce era basata su un'immagine HDR. Forse è per questo che in molti credono che unHDR sia la cosa migliore "in tutti i casi" (interni, esterni, visualizzazioni di prodotto) perché sembra la tecnica preferita dai professionisti più affermati. E cercando online sicuramente avrete trovato discussioni in cui si dice che un'HDR porti a risultati ultra realistici – cosa che in alcuni casi è assolutamente vera... ma non sempre.
La scelta di usare una HDR è una scelta molto sensata per le immagini di esterni, perché la luce viene proiettata da una foto di un cielo reale, quindi può contenere sfumature di colore uniche, ammassi di nuvole particolari, tempeste in arrivo, tramonti emozionanti... tutte cose che (oltre a creare riflessioni interessanti sui vetri senza dover ricostruire manualmente la scenografia dietro la camera, che non è poco) sono capaci di dare al render finale un look e un'atmosfera molto naturali, a volte anche drammatici.


HDRI
Corona Sky + Sun
Le HDR che raffigurano uno studio fotografico poi, semplificano molto il setup della luce nelle visualizzazioni di prodotto, perché vengono create con una serie di foto scattate in uno studio fotografico reale, quindi catturano la posizione delle luci del set, la grandezza, la forma, e tutto ciò che c'è nello studio, che non va costruito manualmente. L'utente non deve fare altro che inserire l'HDR in un Corona Sky, orientare la parte più luminosa dell'HDR dove desidera e verificare che le riflessioni sui metalli, sui vetri e sulle plastiche siano ben distribuite e valorizzino bene le forme del prodotto.

In un interno con finestre di dimensioni "normali" la luce emanata da uno Sky con HDR non arriva in una quantità tale da ottenere un risultato molto diverso da quello che si può ottenere con un Corona Sky (impostato sul modello Physical Sky) e un Corona Sun. La differenza è minima. Per questo motivo non ho mai utilizzato HDR per illuminare i miei interni e quando l'ho fatto (per sperimentare la tecnica) i risultati non mi hanno entusiasmato – ma magari non ho neanche insistito troppo per trovare la formula giusta. Ho sempre preferito una luce basata su Corona Sky (Physical Sky) e Corona Sun.
Qualche anno fa le HDR erano più utili perché erano l'unico modo per ottenere delle nuvole realistiche, ma oggi il Corona Sky può generare nuvole 3d molto belle, controllabili tramite parametri e con cui si possono raggiungere risultati a mio parere strepitosi.
Se non l'avete ancora fatto scaricate questo prodotto gratuito dallo shop e guardate voi stessi quello che si può fare. Anche la scena scandinava che ho utilizzato per molte delle immagini che avete visto in questo post è scaricabile gratuitamente!

Se hai trovato utile e interessante questo post, scrivilo nei commenti e saprò che vale la pena continuare a scrivere contenuti come questo. Se non vuoi perderti i prossimi articoli salva questo blog nei preferiti e torna a dare un’occhiata di tanto in tanto: sto preparando altri post come questo che potrebbero piacerti!

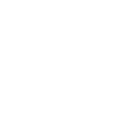















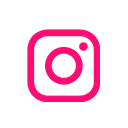





Completo ed esaustivo come al solito Angelo. E' sempre un piacere leggere i tuoi post.
RispondiEliminaGrazie!
EliminaArticolo davvero ben fatto. Nonostante lavori da anni con Cinema4D e Corona, ho trovato spiegazioni chiare e consigli pratici che rendono la gestione di Sky e Sun molto più intuitiva. È raro vedere contenuti che riescono a essere utili sia per chi muove i primi passi sia per chi ha già esperienza: qui c’è la giusta combinazione di teoria e applicazione concreta. Ottimo lavoro, davvero prezioso.
RispondiEliminaGrazie!
EliminaGrazie molte Angelo per il tuo articolo, continua così!
EliminaAngelo - sorry I'm writing on English, I've read the article via google translate and everything is understandable and easy to grasp. I've bought many scenes from you and learned a lot from them. But this article is truly opened my eyes on so many topics and rules, I didn't even know existed. Now I examine your and other's artists work with a new eye and understanding why I like this image\interior and why this grabs my attention. Thank you for this article and your time, hope to read and learn more from you.
RispondiEliminaThank you very much for this feedback!
Eliminaè valido per più motori di rendering non solo corona, insomma una bibbia per me
RispondiElimina